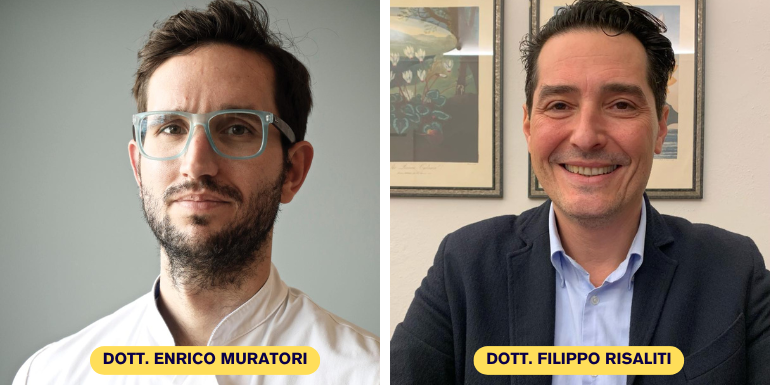Il Venezuela è libero © unsplash
Il Venezuela è libero © unsplash
C’è una parola che rimbalza ossessivamente nel dibattito di queste ore: invasione. Gli Stati Uniti avrebbero “invaso un Paese sovrano”, violato il diritto internazionale, aperto un precedente pericoloso. Ma prima di ripetere slogan buoni per i social e per i battibecchi da salotti tv varrebbe la pena fermarsi su una domanda elementare: di quale sovranità stiamo parlando?
Il Venezuela di Nicolás Maduro non è uno Stato sovrano nel senso pieno del termine da molti anni. È un regime autoritario svuotato dall’interno, infiltrato da potenze straniere, trasformato progressivamente in uno spazio franco per reti criminali, terroristiche e finanziarie transnazionali. Uno Stato formalmente esistente, ma sostanzialmente espropriato delle sue funzioni fondamentali.
L’arresto di Maduro e di sua moglie, avvenuto a Caracas per mano delle forze speciali statunitensi, non è stato un colpo di Stato né un blitz improvvisato. È stata un’uscita negoziata espressione con cui si indica la fine concordata di un potere autoritario attraverso accordi e garanzie, pensata per evitare il collasso istituzionale, la guerra civile o un bagno di sangue. Non è una transizione democratica piena, ma non è neppure un atto di pirateria internazionale.
Chi oggi invoca la Carta delle Nazioni Unite dimentica – volontariamente o meno – che il richiamo al principio di sovranità non equivale a un consenso globale contro l’azione americana. La maggior parte degli attori internazionali riconosce la natura dittatoriale del regime venezuelano. Ciò che divide non è il giudizio su Maduro, ma il metodo. E tuttavia, nel sistema internazionale reale, il metodo non si misura solo in astratto, ma nei rapporti di forza.
Trump può aver forzato il diritto, ma non ha forzato la geopolitica.
Un’operazione di questa portata non si conduce mai in isolamento. Nessuna azione ad alto impatto strategico viene lanciata senza aver preventivamente testato la reazione – o la non reazione – degli alleati chiave: Nato, potenze energetiche, attori finanziari globali, e perfino rivali sistemici come Russia e Cina. Il sostegno, in questi casi, non è necessariamente pubblico è spesso silenzioso, tattico, fatto di accesso a intelligence, controllo degli spazi aerei, neutralità diplomatica.
Se Trump fosse stato davvero isolato, oggi assisteremmo a rotture nei dispositivi militari alleati, a reazioni economiche coordinate, a una crisi diplomatica simultanea su più tavoli. Nulla di tutto questo è accaduto e addirittura la vice presidente di Maduro, non certo un’amica di Trump, è stata investita nella transizione del titolo di Presidente ad interim.
I mercati – che raramente sbagliano la lettura del rischio sistemico – lo hanno capito prima della politica. Le borse asiatiche, già aperte, hanno reagito senza panico: ricomposizione del rischio, non fuga. Segno evidente che l’arresto di Maduro è percepito come uno shock politico rilevante, ma non come un detonatore globale.
C’è poi un elemento che il dibattito occidentale continua ostinatamente a rimuovere: il Venezuela non era più solo venezuelano.
Da circa vent’anni, la Repubblica islamica iraniana ha progressivamente colonizzato porzioni strategiche del Paese. Sotto Chávez prima e Maduro poi, l’asse Teheran–Caracas si è consolidato con investimenti stimati tra i 5 e i 7 miliardi di dollari, una cooperazione opaca e una convergenza ideologica fondata sull’antiamericanismo militante.
Il Venezuela è diventato il Paese latinoamericano con i legami più stretti con l’Iran, offrendo rifugio sicuro a pasdaran e Hezbollah. Intere aree di territorio sono finite sotto il controllo diretto o indiretto dei Guardiani della Rivoluzione. Hezbollah, da tempo radicato in America Latina, ha utilizzato il Venezuela come hub per riciclaggio, traffico di droga e armi, reclutamento e logistica terroristica.
In questo contesto, parlare di “invasione di un Paese sovrano” suona quantomeno ingenuo. O peggio, colpevolmente ideologico.
Non è un caso che l’operazione sia avvenuta il 3 gennaio, anniversario dell’uccisione di Qasem Soleimani. Il messaggio non era rivolto solo a Caracas, ma a Teheran. A Khamenei. Agli “Stati canaglia” che utilizzano regimi falliti come piattaforme avanzate per una guerra ibrida contro l’Occidente.
A completare il quadro c’è poi l’altra grande potenza che ha messo le mani sul Venezuela mentre il dibattito occidentale continuava a recitare il rosario della “sovranità violata”: la Cina. Pechino non ha mai avuto bisogno di milizie, pasdaran o retorica ideologica. La sua ingerenza è stata più silenziosa, più efficiente e forse ancora più pervasiva. Attraverso una pioggia di prestiti, linee di credito opache e accordi bilaterali capestro, la Cina ha progressivamente legato Caracas a sé con un meccanismo ben collaudato: debito in cambio di controllo.
Il Venezuela è diventato uno dei principali destinatari dei finanziamenti cinesi in America Latina, con decine di miliardi di dollari erogati negli anni sotto forma di prestiti garantiti dal petrolio. In pratica, una parte consistente della produzione venezuelana è stata ipotecata per anni, sottraendo allo Stato margini di manovra economica e decisionale. Altro che sovranità: un Paese strangolato dal debito e amministrato per procura.
Ma non si è trattato solo di energia. Le aziende cinesi hanno messo radici profonde nelle infrastrutture strategiche venezuelane: telecomunicazioni, sistemi di sorveglianza, reti digitali, controllo dei dati. Tecnologie importate che non servono solo allo sviluppo, ma anche – e soprattutto – al controllo sociale e politico. Il modello è noto: sviluppo senza diritti, stabilità senza libertà.
In questo senso, il regime di Maduro non è stato soltanto un alleato politico di Pechino, ma un laboratorio. Un banco di prova per l’espansione dell’influenza cinese nell’emisfero occidentale, a poche miglia dagli Stati Uniti. Una presenza che non fa rumore, non spara colpi, ma ridefinisce lentamente i rapporti di potere.
Iran, Russia, Cina. Tre attori diversi, una stessa conclusione: il Venezuela aveva già smesso di essere uno Stato sovrano molto prima dell’intervento americano. Era diventato un territorio conteso, penetrato, utilizzato. Un hub geopolitico dove interessi ostili all’Occidente si sovrapponevano senza più alcun controllo democratico.
Ed è per questo che l’arresto di Maduro non può essere letto solo come un atto unilaterale di forza, ma come la chiusura brutale – e forse inevitabile – di una lunga fase di erosione della sovranità venezuelana, consumata nel silenzio complice di chi oggi grida allo scandalo.